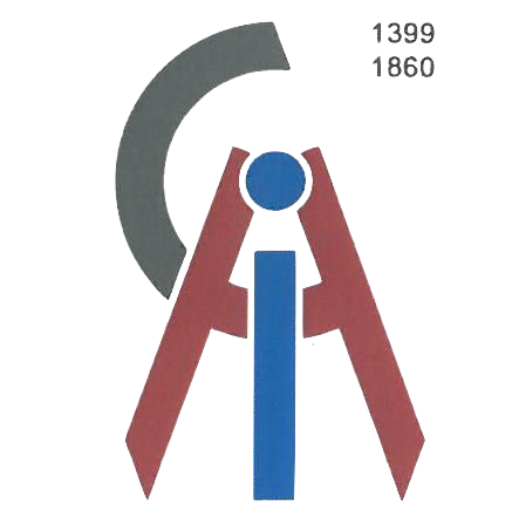Continuità
Presentazione del Presidente ing. Giovanni Rigone.
Sono le guide date dal Duca di Milano nel 1399 agli Ingegneri per andare alle Valli ed alle Paludi del Po a costituire la traccia sulla quale prenderà avvio un processo plurisecolare che approderà alla costituzione tra il 15 ed il 22 dicembre 1859 ed il gennaio 1860 delCollegio degli Ingegneri diPavia.
Le prime attività le riscontriamo il 13 gennaio 1861 con la costituzione di una commissione per valutare l’interesse di Pavia per una stazione ferroviaria in Milano tra Porta Ticinese e Porta Romana ed il 14 luglio dello stesso anno con il rapporto della commissione incaricata di indicare il valico ferroviario preferibile attraverso le Alpi elvetiche.
La costituzione del Collegio rappresenta la conclusione di un percorso che dal 1399 al 1859 registra indicazioni date dall’autorità pubblica a più riprese per l’esercizio della professione di ingegnere, architetto ed agrimensore, oltre a tre tentativi per arrivare alla costituzione del Collegio: 23 agosto 1654, 7 maggio e 1^ giugno 1791, 6 maggio 1810.
Se torniamo alle prime due attività, a Collegio appena costituito, va riconosciuto che queste hanno una sostanziale valenza di servizio verso la comunità. Adesse si possono aggiungere: nel 1861, la determinazione dell’indennizzo in caso di esproprio di terreni suburbani per pubblica utilità e, nel 1864, la partecipazione al 2^ Congresso agrario lombardo in Pavia con la memoria sulla teoria e pratica dell’irrigazione e misura delle acque correnti.
Si perviene infine al 1890 con l’indizione da parte del Collegio di un concorso per progetti di derivazione di acqua dal Ticino per dotare Pavia di forza motrice. La duplice finalità del Collegio, rivolta ad una crescita culturale e professionale dei soci ed alla possibilità di fornire contributi su problemi di interesse pubblico, è tutt’ora una costante. L’art.lo 2 dello statuto in vigore ne dà testimonianza:
Il Collegio è una libera Associazione di ingegneri e di architetti che intende perseguire i seguenti scopi:
a) accrescere e migliorare le conoscenze scientifiche, la preparazione professionale e la cultura dei soci.
b) favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione fra i soci.
c) contribuire all’evoluzione degli studi, delle ricerche e della legislazione al fine di favorire un’equilibrata crescita morale, culturale e sociale della comunità, con particolare riguardo alle sue valenze territoriali ed ambientali ed alla tutela del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico.
d) esprimere il pensiero collegiale sugli aspetti culturali, tecnici e scientifici dei problemi locali, regionali e nazionali e cooperare con studi e proposte interdisciplinari alla messa a punto di soluzioni valide e di pubbliche utilità.
L’attività, sospesa tra il 1927 ed il 1945, riprende con vigore il 10 novembre 1945 con l’approvazione dello statuto del nuovo Collegio degli Ingegneri edegli Architetti di Pavia, titolazione definitivamente assunta nel1956 inCollegio degli Ingegneri edegli Architetti della Provincia di Pavia.
Dal 1945 ai giorni nostri gli interventi e le memorie sugli aspetti culturali, tecnici e scientifici dei problemi locali, regionali e nazionali sono stati innumerevoli.
Tra questi, due in particolare meritano un riferimento puntuale: il Convegno di studio sul centro storico di Pavia del giugno 1964 i cui contenuti hanno segnato il punto di svolta dell’approccio culturale agli aspetti di tutela e conservazione dei centri storici in Italia e non solo e la ricerca Pavia e la Provincia, prospettive per gli anni 2000 per l’indagine e la messa a punto di proposte per il migliore utilizzo del potenziale sociale, economico e culturale della nostra Provincia e per l’individuazione di un quadro infrastrutturale del quale alcune parti hanno già trovato parziale realizzazione in direzione dell’Aeroporto di Malpensa ed altre, sulle direttrici Lomellina ed Oltrepò e Lomellina ed ovest Milano, sono in fase di progetto e di avvio di opere.
Il Consiglio Direttivo è lieto, nel 150° anniversario della fondazione, di aggiornare per il periodo che va dal 1985 al 2010 la pregevole opera dell’antico ed illustre socio Prof. Ing. Alberto Gabba, al quale va qui, ancora, il più vivo grazie per aver percorso con competenza storiografica i primi 125 anni dell’attività del Collegio, restituendoci, nella riproduzione anastatica della prima parte dell’opera che oggi viene presentata sui 150 anni del Collegio, un quadro completo dell’evoluzione che ha caratterizzato la professione dell’ingegnere e dell’architetto, il contesto sociale ed istituzionale che ne hanno determinato le motivazioni e le norme di comportamento, la necessità assoluta di un costante aggiornamento professionale e culturale, l’esercizio di uno spirito di servizio che concorre alla crescita civile della comunità nella quale si opera.
Il 2009 registra l’aggiornamento delle strutture collegiali, ferma restando la duplice finalità rivolta alla crescita culturale dei soci ed al fornire contributi di servizio su problemi di interesse pubblico.
Le attività sono ora condotte all’interno di quattro settori: conoscenza puntuale che comprende le visite tecniche e l’aggiornamento cognitivo; interessi culturali; rapporti con le istituzioni universitarie; comunicazione con i soci, visibilità e ruolo di ricerca e di servizio del Collegio.
Nell’ultimo decennio rilevante è stata l’attività nell’ambito del Comitato Interprofessionale Edile della Provincia di Pavia costituito, oltre che dal Collegio, dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, dal Collegio dei Geometri e dal Collegio dei Costruttori edili.
In questo organismo è confluita la trattazione, la redazione di memorie e di osservazioni in tema di pianificazione urbanistica a livello locale e regionale e di problematiche regolamentari per le discipline ambientali, di risparmio energetico e di fonti energetiche rinnovabili.
Nel quadro di questo impegno di servizio, a fine ottobre 2009 è stato sottoscritto dal Comitato Interprofessionale edile un accordo con il Comune di Pavia per facilitare la messa a punto dei contenuti e dell’iter di presentazione delle pratiche edilizie ed urbanistiche. Analoghe attività sono in fase di avvio con i Comuni di Vigevano e Voghera.
Questo modo di operare è stato molto bene sintetizzato dalla Camera di Commercio di Pavia quando il 18 dicembre 1988 haconferito al Collegio una menzione speciale con la seguente motivazione: PARTICOLARMENTE ATTENTO NEL PROMUOVERE LA CONOSCENZA E L’INDAGINE SCIENTIFICA E CULTURALE DEI PROBLEMI CORRELATI ALLE DISCIPLINE DELL’ARCHITETTURA E DELL’INGEGNERIA, E’ PARTE VIVA E CONTINUA DELL’EVOLUZIONE CHE HA CARATTERIZZATO LA SOCIETA’ PAVESE NEGLI ULTIMI 125 ANNI.
L’ultimo scorcio del 2010 registra le due ultime iniziative del Collegio:
- La partecipazione il 16 settembre 2010, nella Sala Conferenze del Broletto, a PAVIA, FESTIVAL DEI SAPERI, DIALOGHI SULLE LIBERTA’ TRA POSSIBILITA’ E LIMITI; il contributo presentato è consistito in un excursus sui 150 anni del Collegio, la più antica associazione culturale pavese: 150 anni di impegno per il territorio tra realtà, prospettive, possibilità e limiti: il contributo del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Pavia.
- Il Caffè scientifico, due chiacchere ed 1 happy hour; incontro aperto al pubblico presso un noto locale del centro della città e teso a trattare aspetti interdisciplinari tra scienza, coscienza e conoscenza. Il Caffè si onora di aver ricevuto il patrocinio dell’Associazione Alunni dell’Università di Pavia, del Comune di Pavia e della Provincia di Pavia.
Il 2011 segna un ulteriore progredire delle attività con il Caffè scientifico che ospiterà tra ottobre 2010 e giugno 2011 ben nove incontri su temi di attualità che hanno connessione con l’ingegneria e l’architettura.
Il 12 marzo l’Aula Foscolo ospita in Università il Convegno che solennizza i 150^ anni del Collegio. Esce 150 ANNI, pubblicazione che traccia il panorama dell’impegno collegiale a partire dal 1861 sino al 2010.
L’avvio dell’autunno vede il Collegio ancora impegnato nel Festival dei Saperi con due relazioni sui temi della bioingegneria.
Tutto quanto è stato realizzato è il frutto di una multiforme attività dei soci condotta con intelligenza, competenza, amore per la propria professione, un sistematico aggiornamento culturale e con la dignità del proprio ruolo nella società.
Oggi, forse come non mai, il Collegio ha di fronte a sé la possibilità di continuare a conseguire con successo i risultati che 150 anni di impegno sono in grado di prospettare. Una costante dovrà sempre caratterizzarne, come è avvenuto sino dalla fondazione, l’attività: creare le condizioni per una crescita culturale, professionale e civile dei soci e, nel contempo, trasferirne i contenuti in un’azione di sostanziale servizio versola comunità. E’ questa una responsabilità che va percepita nel rispetto della tradizione ultrasecolare e nello spirito di ben operare che i soci hanno testimoniato dalla fondazione sino ad oggi.
11 gennaio 2012.
INTERVENTO PROF. GUDERZO
Ingegneri e Architetti a Pavia
Nel 150° di fondazione del loro Collegio
Se, in fortunata e significativa consonanza con le celebrazioni del 150° dell’unificazione italiana, siamo in grado di far memoria della fondazione, centocinquant’anni or sono, del Collegio degli Ingegneridella provincia di Pavia, lo dobbiamo alla passione, oltre che al fiuto, di Alberto Gabba. Che, già per il 125° di fondazione del Collegio, a seguito di lunghe, accurate indagini, aveva potuto approntare e poi dar alle stampe una precisa ricostruzione delle vicende del sodalizio, pervenendo a fissarne documentalmente la data ufficiale di nascita a Pavia pochi mesi dopo la conclusione della campagna militare del ’59.
Muovendo dai primi documenti, di fine Trecento, sull’attività di ingegneri pavesi, ritrovati negli archivi pubblici, e via via risalendo sulla scorta delle gride ed atti conservati nel nostro archivio storico civico lungo il Quattro, Cinque, Sei e primo Settecento, lo studioso aveva in quell’occasione potuto offrire una prova sicura dell’operosa presenza dell’arte in Pavia e nel suo Principato tra Medio Evo ed età moderna, pur in assenza di quell’istituto – il Collegio, appunto – di tanto più tarda fondazione.
Di che cosa poi si occupassero quegli ingegneri, almeno nelle attività – diremo così – pubbliche, documentate nell’archivio della città, è presto detto: “fabrica delle mura”, “mensurationes” diverse, “stima de siti”, livellazioni e ispezioni in preparazione allo scavo del “novo Naviglio da Milano a Pavia”, “recognitioni” in vista di un “disegno in foglio grande del sito” della “città, e Principato con tutte le ville, luoghi, fiumi, ed altro solito mettersi in simili disegni”, “nuova fabrica della Cattedrale” e disegno del suo coro, nonché interventi a difesa dell’arte.
I documenti pubblici nulla tuttavia dicono di quel che viceversa doveva essere il principale loro impegno, letteralmente “sul campo”, avendo direttamente a che fare con un’agricoltura – la nostra – che pur era venuta tra Medio Evo ed età moderna conquistando una primazia a livello europeo: riconosciuta tra l’altro da illustri viaggiatori ed esperti come quell’Arthur Young che non esitava a proporre a fine Settecento le nostre campagne ad esempio per le inglesi. Le quali poi – le inglesi – giusto allora, pur stavano conoscendo straordinarie trasformazioni strutturali, strettamente legate a quella rivoluzione economica che della Gran Bretagna avrebbe fatto in pochi decenni la massima potenza economica (e politica) a livello planetario.
La nostra regione, con particolare riguardo ai territori compresi tra i confini meridionali dell’altopiano e il Po, già interessata sin dall’età classica da una prima colonizzazione, sviluppata poi nel Medio Evo con la crescente inalveazione e corrispondente impiego delle acque, stava conoscendo nel Settecento e avrebbe ancor più intensamente conosciuto nell’Ottocento, in modo più accentuato in talune aree, quale, ad esempio,la nostra Lomellina, un ulteriore, straordinario processo di trasformazione che investiva strutture fondiarie e colture, traendo la propria ragion d’essere da interventi di grande ingegneria idraulica. Protagonisti di questo processo, inutile dirlo, i nostri ingegneri: accanto e per delega, in modo particolare, della grande proprietà, ecclesiastica e laica prima, quasi solo laica dopo gli eventi rivoluzionari di fine Settecento e primo Ottocento.
Maestri riconosciuti nella signoria delle acque, gli ingegneri lombardi potevano a ragione vantarsi d’aver preceduto sin dal Medio Evo gli altri grandi costruttori di canali – fiamminghi, francesi, inglesi – con imprese come i Navigli, l’ultimo dei quali, il nostro, pavese, inaugurato nel 1819, sarebbe stato a quella data senz’altro tecnicamente il più avanzato a livello europeo. Quella maestria era poi frutto soprattutto, anche se non soltanto, di pratica: una pratica che si apprendeva nel lavoro accanto al “capobottega”, un ingegnere esperto, che a sua volta l’aveva appresa, e al caso perfezionata, lavorando accanto a un precedente maestro. Ché se volessimo far il nome di un “pratico”, sommo maestro anche in questo settore, a dirci quanto la concreta esperienza appunto contasse per fare un buon ingegnere, potremmo facilmente buttar lì quello di Leonardo, che tra l’altro lavorò anche a Pavia.
Se quei lavori che avevano via via ristrutturato tanta parte del territorio lombardo – e nella fattispecie pavese – costituivano l’aspetto per così dire “straordinario” dell’impegno ingegneristico, si dava poi un’attività diremo “ordinaria”, alla prima evidentemente collegata in via continuativa, consistente nella corretta gestione dei rapporti economici in essere tra i proprietari, presenti o meno che fossero sui fondi, e quegli straordinari imprenditori agrari che erano i fittabili, ai quali poi si doveva se i fondi idraulicamente sistemati erano in grado di offrire rendite corrispondenti all’impegno finanziario in essi trasfuso. Sicché la sorveglianza sulla buona gestione dei fondi, con un’attenzione speciale al corretto utilizzo delle connesse “ragioni d’acqua” e le stime e valutazioni legate alle cosiddette “consegne” e “riconsegne”, a inizio e conclusione di affittanze generalmente pluriennali, rappresentavano il più normale impegno dei nostri tecnici.
Donde, come in altre professioni più o meno vicine a questa – pensiamo in particolare al notariato, ma anche all’avvocatura – la naturale formazione di vere e proprie dinastie professionali – come nel caso pavese, spesso ricordato, degli Andreoli, ma non è che un esempio dei molti possibili – nelle quali il buon mestiere si tramandava per così dire “naturalmente” di padre in figlio. Perché chi si affidava a quel dato studio sapeva di poter contare sull’assoluta, specchiata probità oltre che su una provata competenza del tecnico in tal modo impegnato.
Se tanto contavano pratica ed esperienza, sarebbe però sbagliato concludere che poco per quei tecnici contassero i buoni studi. Perché si davano scuole nelle quali si affrontavano temi e problemi generali, la cui conoscenza era pur ritenuta il necessario viatico per poi operare al meglio. Quei “pratici”, d’altronde, non per caso potevano annoverare tra le loro stesse file colleghi che all’attività appresa ed esplicata sul campo univano il gusto per la sistemazione delle conoscenze utili alla stessa soluzione dei problemi che sul campo si presentavano e dovevano esser quindi convenientemente affrontati.
Senza imbarcarci in una disamina della letteratura tecnica, manoscritta e a stampa, sicuramente circolante in Pavia ancora nel secolo XVIII, valga qui almeno la citazione di due titoli, senz’altro di per sé significativi, frutto dell’esperienza oltre che dei buoni studi di un ingegnere lombardo, Antonio Cantalupi, pur operante in tutt’altra temperie, nel secolo successivo: il fortunato Manuale delle leggi, regolamenti e discipline intorno alle strade, alle acque ed alle fabbriche non che ad altri rami relativi alla professione dell’ingegnere ed architetto civile, del 1845, e le Nozioni pratiche intorno alle consegne, riconsegne e bilanci dei fondi stabili, del ’47. Cui varrà la pena di aggiungere, proprio perché di tutt’altra origine, legata com’era all’iter scolastico dei futuri ingegneri, la Guida – edita nel 1852 a Pavia – allo studio economico rurale elementare di Carlo Pasi, all’epoca docente nel nostro Ateneo.
Quanto per far un buon ingegnere – ma anche un buon uomo di legge o d’altra professione – contasse la formazione scolastica, quanto l’apprendimento sul campo, fu peraltro questione che appassionò non poco le élites europee nell’età che siamo soliti definire “moderna”, venendo variamente risolta, secondo due modelli che potremmo definire l’uno insulare o britannico, l’altro continentale o francese, il primo prevedendo possibili percorsi formativi diversi, l’altro un solo itinerario, principalmente fondato sulla presenza e obbligatoria frequentazione di scuole adeguate.
In Lombardia, la facoltà di organizzare e regolare l’accesso alle professioni poi dette liberali era stata demandata nel secondo Cinquecento ad organi di natura corporativa, come nella nostra fattispecie il milanese Collegio degli ingegneri, prevedendo itinerari formativi che avevano tra l’altro concorso ad eliminare il monopolio nella concessione dei titoli di studio attribuito in età ducale al nostro Ateneo, avviandone così, in pratica, la lunga decadenza, tra Cinque e Settecento.
Una decadenza – ricorderemo – dalla quale l’Ateneo pavese sarebbe stato riscattato solo con quella “rivoluzione del sistema”, come da Vienna allora la si definì, destinata a produrre, in età teresiana e giuseppina, radicali trasformazioni, come in altri fondamentali settori, anche nell’ingegneria così come allora la si apprendeva e praticava. Sicché Pavia, dove all’istituzione di un Collegio come a Milano si era inutilmente tentato di dar vita nel corso del Seicento, si sarebbe vista restituire il menzionato monopolio, valido come per le altre anche per la professione d’ingegnere. Che veniva così, almeno ufficialmente, sottratta al tradizionale iter d’accesso. Un percorso, ricordiamo, che contemplava la cosiddetta “militanza”, ossia l’apprendistato e tirocinio sotto la direzione di un ingegnere. Il quale, in questo universo agevolmente riconoscibile come corporativo, assumeva le funzioni già ricordate di capobottega o, se si preferisce, di maestro d’arte.
Ancora Gabba opportunamente nota come alla mancanza di un Collegio simile a quello di Milano avesse in precedenza supplito da noi la civica amministrazione, ufficialmente incaricata del rilascio delle licenze d’esercizio della professione: una commissione nominata dal civico Tribunale di provvisione, solitamente formata da due ingegneri, vagliando “condizione, voce e fama” degli aspiranti al titolo, e relazionando sulle prove d’esame pubblicamente effettuate. Superate le quali, i candidati erano tenuti a promettere di esercitare l’arte “rettamente, legalmente e con fedeltà”, osservando tutte le disposizioni relative alla professione. La pratica di ammissione risultando completata, peraltro, solo con l’avallo di un fidejussore a garanzia futura del comportamento richiesto.
Se le riforme teresiane e giuseppine avevano sottratto ai diversi Collegi la competenza sulla formazione di base dei futuri professionisti, il loro prestigio, fondato sui virtuosi circuiti delle relazioni intrattenute dai loro membri più stimati e influenti con l’élite locale, restava inevitabilmente alto, tra l’altro, nel caso degli ingegneri, essendo stato ad essi attribuito, ancora nella Restaurazione, un compito essenziale: seguire il tirocinio biennale dei giovani che, licenziati dall’Università dopo l’obbligatorio triennio di studi, aspirassero all’ingresso nella libera professione.
Che questa – la libera professione – restasse meta ambita in un panorama economico ancora prioritariamente legato a scala non solo regionale all’agricoltura, quest’ultima, per di più, ed ancora, soggetta a importanti interventi di ingegneria idraulica, non può certo stupire, pur in presenza di opportunità diverse che tra Sette e Ottocento, con una particolare accelerazione in età francese, erano venute interessando il nostro settore. Ciò, ricorderemo, traendo spunto da quei rivoluzionari interventi sulle vie di comunicazione che avevano portato, tra l’altro, soprattutto in età napoleonica e nei primi anni della Restaurazione (ma non senza significativi precedenti nel secolo precedente) alla rotabilizzazione di alcuni tra i maggiori valichi alpini ed appenninici, avendo il proprio punto di forza teorico- pratico nella francese Ecole des ponts et chaussées. Sicché l’impiego nelle rinnovate pubbliche strutture di supporto – come il cosiddetto Genio Civile – a quella che potremmo definire ingegneria del territorio era venuto acquistando, nelle scelte dei neoingegneri, un interesse e un peso ignoti alle generazioni precedenti.
Di scuola francese sarebbero stati, tra l’altro, alcuni tra i più noti ingegneri chiamati negli Stati preunitari, a Torino come a Firenze o Napoli, a reggere il timone dei grandi lavori, prima stradali poi ferroviari, destinati in breve volger d’anni a trasformare profondamente il Paese, la sua economia, gli stessi stili di vita dei suoi abitanti. A quelle stesse trasformazioni, straordinariamente accelerate dall’unificazione italiana, si sarebbe poi legato il successivo sviluppo di altri settori occupazionali, per la crescita dei centri urbani: vieppiù accelerata, dalla fine degli anni Settanta, per la nuova, progrediente industrializzazione.
Le carte non ci dicono che cosa precisamente avesse indotto alcuni tra i più stimati ingegneri pavesi – Franchi, Orlandi, Crespi, Capsoni – a riunirsi più volte, nelle ultime settimane del 1859, al fine di stendere lo Statuto di un costituendo Collegio degli Ingegneri. Indubbiamente, l’aria che tirava in quei mesi a Pavia come a Milano e Torino, ma non solo, doveva essere senz’altro frizzante e invogliar a fare. Non abbiamo il testo, presumibilmente rimasto manoscritto, di quel primo Statuto, l’unico pervenutoci, a stampa, portando la data del 1887 ed essendo già inclusivo degli architetti.
Da questo dell’ ‘87 quel primo di 150 anni fa non doveva però forse troppo discostarsi, almeno per quanto riguardava lo scopo della nuova associazione, così precisato all’art. 6: «promuovere e contribuire con uniformità di giudizio al progresso scientifico e pratico di tutto ciò che si riferisce ai vari rami dell’Ingegneria e dell’Architettura diffondendo cognizioni e sviluppando principî di associazione in quanto siano attinenti alla professione». Aggiungendo all’art. 7 – e si tratta di un aspetto tutt’altro che marginale, singolarmente consonante con un analogo presente nello Statuto del Collegio milanese, di poco posteriore al nostro – che «Il Collegio si presta, quando lo crede opportuno, alla soluzione dei quesiti di massima e di applicazione immediata che, circa le professioni dell’Ingegnere e dell’Architetto, gli vengono presentate dai Soci, dalle Autorità politiche, giudiziarie e amministrative, dai Corpi morali o da un privato qualunque», mentre si rinviava al Regolamento interno per la copertura delle spese eventualmente sostenute dalle commissioni nominate dal Collegio in ordine alla soluzione dei quesiti proposti dai Corpi morali e dai privati nonché per il saldo delle “competenze” dovute ai membri delle medesime commissioni.
Chi come il nume tutelare del Collegio pavese – l’ing. Luigi Canepari– ha avuto l’inconsueta ventura di attraversare un secolo di trasformazioni profonde, nella fattispecie anche del settore ingegneristico nel suo vario rapportarsi alla società in cui si è via via trovato a operare, non può che guardare con speciale interesse a indicazioni e regole comportamentali come quelle ora menzionate, singolarmente attuali almeno per il “suo” Collegio così come è venuto configurandosi negli anni più recenti.
In quell’originaria configurazione, il Collegio pavese, non diversamente, del resto da tanti altri via via sorti nel Paese con una significativa accelerazione tra il 1885 e il ‘95, dichiarandosi aperto alla partecipazione non dei soli Ingegneri e Architetti, bensì pure dei «Dottori e Studenti in Matematiche – così precisamente l’art. 2 dello Statuto pavese – e di altre persone, le quali si occupano specialmente di studi tecnici ed industriali, che hanno una diretta applicazione all’Ingegneria ed all’Architettura» non presenta infatti, evidentemente, le caratteristiche proprie di un ordine professionale.
Come è stato autorevolmente notato, se per un verso il loro dichiarato interesse allo studio e discussione di questioni relative ai rispettivi campi di lavoro apparenta i Collegi ad “accademie e associazioni” di studiosi di varia origine presenti nel Paese, la funzione di consulenza, pure precisata nei diversi Statuti, li «avvicina al mercato della professione». In ogni caso, «pur esercitando un’indubbia funzione di rappresentanza, non sono un luogo deputato alla difesa degli interessi economici della categoria». Di questa speciale configurazione, contro altre da più parti propugnate e più o meno tendenti a una tutela – diremo così – sindacale degli iscritti, l’assertore determinato e vittorioso sarà, dai primi anni Sessanta dell’Ottocento alla conclusione della “Grande guerra”, il Collegio di Milano.
Che poi, per quelle caratteristiche, il Collegio, in una realtà come nella fattispecie la nostra, pavese, dovesse (e debba…) scontrarsi con difficoltà di vario genere, innanzi tutto economiche, ma non solo, è altro discorso: non diversamente da altri sodalizi, nei più diversi campi, la loro vitalità come l’originalità delle iniziative via via assunte dipendendo, d’altronde, sia dal contesto socioculturale col quale venivano e vengono interagendo, sia dalla personalità di chi li guida. Sicché non ci dovremmo poi troppo stupire per la buona qualità dei primi “prodotti” del Collegio pavese, a cominciare da quello – a scala non solo regionale il più noto – sulla scelta del valico ferroviario nelle Alpi centrali.
Datato 1861, quindi pressoché a ridosso della stessa ufficiale costituzione del nostro Collegio, inserito nell’11° volume del “Politecnico” ma largamente diffuso in estratto, si tratta del Rapporto di una commissione del genere di quelle precisamente indicate dall’art. 7 dello Statuto. La ben argomentata difesa della scelta più “lombarda” del valico, ossia per lo Spluga, reca le firme di Carlo Pasi, Giovanni Crespi, Giovanni Codazza, essendone quest’ultimo il relatore.
Basterebbe quest’ultima indicazione a farci intendere come e perché il Collegio pavese potesse essere così precocemente presente su un fronte allora tanto caldo. Professore di geometria descrittiva nella Facoltà matematica pavese, Codazza già dal 1856 aveva qui assunto l’incarico di “scienza della costruzione delle macchine”. Rettore dell’Ateneo nel 1857-‘58, sarebbe stato sindaco di Pavia dal ’62 al ’63. Passato poi ad insegnare Fisica tecnologica a Milano, nell’Istituto creato dall’indomita volontà di Brioschi, , ulteriormente trasferendosi a Torino, nel ’68, qui dal ’70 avrebbe diretto il Museo industriale, componente essenziale nella nascita del Politecnico subalpino. Né andrà, di quella commissione, trascurato il nome dell’altro docente della nostra Facoltà matematica, quel Carlo Pasi che già abbiamo incontrato e lascerà presto lui pure Pavia per Milano.
Chi abbia presente l’intreccio di attività – scientifiche, didattiche, amministrative, sociali, politiche – che a Milano accompagnarono l’iniziativa fondamentale – la creazione dell’Istituto Tecnico Superiore, il futuro Politecnico – assunta dall’altro grande docente giusto in quel torno di tempo “perduto” da Pavia e testé menzionato, Francesco Brioschi, e tra quelle, si badi, la stessa rinascita in nuove forme dell’antico Collegio, non ha difficoltà a intendere il significato paradigmatico della partecipazione di Codazza a una tra le prime pubbliche “uscite” del Collegio pavese. Perché si trattava, detto in breve, di legare le attività eminentemente formative di una scuola ad hoc con la valorizzazione dei suoi specifici “prodotti”, ossia degli ingegneri, interagendo in profondità con la società di appartenenza. E ciò, innanzi tutto, evitando di riprodurre – pur in una temperie culturale e sociopolitica senz’altro, ma solo in parte, diversa – la dicotomia che aveva afflitto generazioni di licenziati e pratici dell’arte tra Sette e Ottocento.
Che poi a Pavia potessero prodursi gli straordinari frutti che l’iniziativa di Brioschi avrebbe ottenuto a Milano è discorso senz’altro obsoleto, restando comunque lecito dubitarne, la stessa concatenazione dei fatti seguiti all’esito della riunione della Lombardia al Piemonte valendo di per sé a provare che Pavia non avrebbe avuto, al riguardo, pressoché nessuna chance. Di certo la perdita di eccellenti studiosi, non solo, ma altresì di eccezionali organizzatori di cultura, capaci di “pensare in grande”, attivando reti e sistemi in grado di legare iniziative imprenditoriali e politiche, non avrebbe potuto non segnare in negativo, sul lungo periodo, l’ingegneria pavese. E se ne sarebbero visti presto i frutti, nel progressivo venir meno dell’iniziale vivacità del nostro Collegio. Le cui poche pubbliche “uscite” non avrebbero più raggiunto, sino ed oltre l’inizio del nuovo secolo, non solo o non tanto la qualità intrinseca dei relativi “prodotti”, quanto la capacità di dialogo col mondo scientifico, economico e politico – non solo locale – caratteristico delle prime.
Beninteso, l’Ateneo pavese, pur accusando la perdita di un settore d’avanguardia, potenzialmente – e presto praticamente – tanto innovativo, sarebbe restato una realtà scientifica e più generalmente culturale di tutto rispetto, avendo in pratica conservato il monopolio nella formazione della maggior parte degli studenti soprattutto lombardi che si iscrivevano all’Università, tanto più in quanto sempre dotata di quei Collegi universitari di merito da tempo capaci di attrarre a Pavia giovani eccellenti intelligenze. Questo, non dimentichiamolo, in una regione già allora economicamente e socialmente tanto avanzata.
Andrà pure sottolineato come l’unione della Lombardia al Piemonte, se foriera di quella dolorosa perdita, già però avesse arrecato e stesse ulteriormente per arrecare vantaggi estremamente importanti alla nostra città: immediatamente sottratta, per la sola circostanza di quella riunione, all’isolamento in cui era stata confinata dalla politica europea tra Sette e Ottocento, tagliata fuori dai principali assi di transito tra Genova e l’oltralpe elvetico e germanico, per di più avendo perduto la maggior parte del suo antico Principato, con la conseguente, progressiva deviazione di gran parte dei tradizionali flussi mercantili e finanziari che ne avevano per secoli sostanziato l’economia.
Non per niente, l’attenzione del nostro Collegio si sarebbe pure, subito, rivolta a quel collegamento ferroviario diretto da una parte con Milano, dall’altra con Genova, che l’ostilità piemontese le aveva a lungo negato. E le opzioni avanzate sempre in quel vorticoso 1861 sul percorso via-Locate in luogo di quello per Binasco e sulla collocazione della stazione immediatamente fuori dalla cinta muraria pavese avrebbero nei fatti dimostrato piena validità.
Inutile dire che trattare del valico alpino senza contemporaneamente – ma per la precisione ancor prima – battersi per il più vantaggioso collegamento con Milano e Genova sarebbe stato un inutile, utopico agitarsi, che all’intelligente concretezza di quegli uomini non apparteneva. L’apertura al traffico della tratta da Rogoredo a Pavia nel 1862, seguita nel ’67 dalla Pavia-Voghera, che aveva comportato la costruzione del cruciale ponte sul Po a Mezzana Corti, avrebbe di lì a poco liberato Pavia dal suo secolare isolamento. L’apertura nell’82 del valico ferroviario nelle Alpi centrali (anche se non all’amato Spluga) avrebbe poi ulteriormente contribuito ad avviarne la progressiva industrializzazione. Alla quale pure il Collegio si sarebbe in seguito interessato, mentre la ricostituzione, in forme ovviamente diverse, dell’antica Provincia già era tornata a far di Pavia un centro anche per altri versi attrattivo a scala non solo locale.
Se il Collegio degli Ingegnerie Architetti di Pavia poco avrebbe fatto udire la propria voce in quanto sodalizio negli anni immediatamente seguenti – risultando circoscritte le sue iniziative “sociali” alla presentazione al Congresso Agrario tenuto a Pavia nel ’64 di una memoria sullaTeoria e pratica dell’irrigazione e alla promozione della pubblicazione nel ’66 di un testo pure relativo a problemi idraulici – sarebbe quanto meno ingeneroso dimenticare l’operosa partecipazione individuale dei suoi membri alla vita economica e sociale della città e provincia, ma non è questo il luogo deputato a trattarne, bastando per ciò indirizzare, una volta di più, l’eventuale curiosità degli interessati alla lettura delle pagine che meritoriamente ancora Alberto Gabba ha loro dedicato nel saggio più volte citato. Sarà però il caso di notar qui, sia pur a margine, come il progressivo venir meno del nostro Collegio nelle funzioni inizialmente e con tanto slancio abbracciate trovasse un buon correttivo nella partecipazione individuale di nostri tecnici alle attività del Collegio milanese, ciò che, del resto, avrebbe avuto modo di ripetersi anche in anni a noi più vicini.
Chi, comunque, anche tra i pavesi, a fine novembre del 1914, si fosse trovato a partecipare alle congiunte celebrazioni milanesi del cinquantenario di istituzione del Politecnico e della rifondazione di quel Collegio (ricco allora di poco meno che settecento associati) non avrebbe certo immaginato di partecipare a una specie di rito di commiato da una realtà destinata in breve volger d’anni a subire profonde trasformazioni.
La guerra che, sei soli mesi più tardi, avrebbe coinvolto – e quanto drammaticamente – anche l’Italia era destinata a modificare radicalmente quei sapienti equilibri tra diverse possibili opzioni che Brioschi prima, poi il suo allievo Colombo (lui pure, potremmo annotare con una punta di campanilismo, di scuola pavese) erano riusciti a imporre a livello nazionale, in pieno accordo col Collegio alla cui guida essi pure si erano, del resto, con altri colleghi, alternati.
L’impronta profondamente liberale degli Statuti, trasfusa nelle modalità di espressione delle associazioni professionali che a quella milanese si erano venute – non senza opposizioni – conformando nel Paese, doveva cedere il passo alla volontà riformatrice soprattutto delle più giovani leve anche milanesi. Che da quelle impostazioni tradizionali né durante la guerra, né subito dopo, si erano sentite sufficientemente difese e valorizzate. E ciò in una temperie socioeconomica e politica che metteva in forse ogni antica certezza, fin anche nella pur sempre ricca e civilmente avanzata Lombardia.
Di qui, a sei soli mesi dalla conclusione del conflitto, la costituzione dell’Associazione Nazionale degli Ingegneri ed Architetti Italiani (Aniai) che trovava eco e seguito concreto anche a Pavia, all’inizio del ’21, ad iniziativa dell’ing. Pietro Morandotti, le cui dichiarazioni programmatiche, alla riunione tenuta per la costituzione di un’associazione locale intesa ad aderire a quella nazionale, sono di per sé significative: trattandosi, come nei Collegi precedentemente in essere, di «promuovere l’incremento scientifico artistico e tecnico dell’ingegneria e della architettura», ma altresì di «curare gli interessi di classe locali» e per ciò di «appoggiare l’Associazione Nazionale degli Ingegneri Italiani nel suo mandato». D’altronde, una voluta discontinuità con la precedente forma associativa trovava espressione nella mancata integrazione della vecchia alla nuova denominazione, che lo statuto nazionale dell’Aniai pur avrebbe consentito.
Nell’autunno ancora del 1921, un’assemblea generale della Sezione pavese approvava, significativamente, una “Tariffa delle competenze per le prestazioni professionali dell’Ingegnere in lavori di Ingegneria Civile, Industriale, Rurale e di Architettura”. Ma era il suo canto del cigno, perché il Fascismo, ormai avviato a diventare regime, intendeva avocare alle proprie organizzazioni i settori ritenuti funzionali a direttrici di marcia nelle quali, per la fattispecie, ingegneri e architetti avrebbero dovuto occupare posizioni strategiche.
Dal Regime, le due categorie sarebbero poi state effettivamente in vari modi gratificate, anche se la politica urbanistica ed edilizia, tesa allora al rinnovamento dell’habitat non solo urbano, non avrebbe, specialmente in provincia, raggiunto quell’ampiezza di interventi che le brillanti riviste tecniche e la più avanzata progettazione all’epoca auspicavano. Da vecchio innamorato di Pavia, mi si consenta di chiosare che la più o meno cronica mancanza di mezzi finanziari adeguati alla incisività delle operazioni progettate avrebbe salvato, con altri centri storici, anche il nostro. Perché gli ardimentosi piani messi a punto negli anni Trenta, se eseguiti, l’avrebbero decisamente stravolto.
Beninteso, l’ingegneria non si esauriva nel settore “civile”, e sarebbe sbagliato dimenticare il suo apporto all’ulteriore crescita economica, specialmente industriale, del Paese, essendone quei tecnici una colonna portante.
Ai sindacati fascisti la via alla tutela delle due categorie era stata indicata ancora dall’Aniai, nel progetto di costituzione degli Ordini professionali realizzato già nel ’23, con la conseguente pubblicazione dei relativi Albi, prima unico per le due categorie, poi, dal ’34, separati. Frattanto, sciolta l’Aniai, le sue sezioni erano state d’autorità convogliate nei nuovi sindacati.
Spazzato via, dieci anni dopo, dai suoi stessi tragici errori, il Regime lasciava infine eredità che le risorte strutture democratiche avrebbero poi conservato. Tali gli Ordini ed Albi professionali, a proposito dei quali andrà tuttavia ricordata la lunga battaglia, cui già si è accennato, combattuta da più parti, in tempi democraticamente non “sospetti”, contro i milanesi che a simili salvaguardie sempre s’erano opposti. Né altresì dimenticando che di tutela e di Ordini si era ampiamente discusso, come poc’anzi notavamo, in quel primo dopoguerra: che ancora era, a tutti gli effetti, “democratico”, anche se incubatore di soluzioni politiche autoritarie, rosse o nere che fossero.
Nel 1945, la voglia di riscoprire o comunque tornar a valorizzare modalità associative negate d’imperio dal Regime, attribuendo loro capacità, presumibilmente autorevoli, di intervento nei dibattiti su scelte operative che investivano la gran maggioranza dei cittadini, era sicuramente forte e diffusa, come potrebbe provare, anche solo a scala locale, la quantità di periodici e fogli stampati, a Pavia come pure in anche minori località provinciali, nei primi mesi seguiti alla fine del conflitto.
Precisamente in questo clima si collocava l’assemblea tenuta a Pavia il 10 novembre di quell’anno, le cui finalità si situavano, peraltro, su una linea di sostanziale continuità con la realtà precedente, testimoniata sin anche dai termini e dall’aggettivazione utilizzati. L’intento dichiarato della proposta di statuto fatta propria dalla rinata associazione, ribattezzata “Collegio degli Ingegnerie Architetti di Pavia”, era infatti «valorizzare, coordinare e tutelare l’attività degli Ingegneri e degli Architetti nell’interesse della categoria e di quello supremo della Nazione».
Risorta dalle sue ceneri anche l’Aniai, ma in forme più liberalmente federative, il sodalizio pavese le si assocerà già dal ‘51, riconoscendovi le proprie stesse finalità generali, precisate nella distinzione dei compiti istituzionali rispetto agli Ordini professionali, ai quali restavano assegnate la funzione di magistratura, regolata a termini di legge, la disciplina e il controllo degli iscritti attraverso l’albo, mentre alle associazioni erano demandate l’azione sindacale e la promozione culturale.
Decisa poi, nel ’60, la scissione tra la prima e la seconda, con l’istituzione della Confederazione dei Sindacati degli Ingegneri e Architetti, l’Aniai si sarebbe proposta obiettivi anche più ambiziosi nella promozione in varie direzioni della cultura professionale, pur dovendo pagare in seguito lo scotto di progressive difficoltà soprattutto finanziarie, che ne avrebbero inevitabilmente indebolito, dalla fine degli anni Sessanta sino a mezzo almeno degli anni Ottanta, peso e potenzialità di espressione a livello nazionale.
Mi pare in ogni caso significativo che l’operazione culturale ancor oggi ricordata come fondamentale nel palmarès del Collegio pavese – il Convegno sul nostro Centro storico – si collochi precisamente in quel periodo. Significativo sembrando altresì che la scelta allora effettuata a livello nazionale risulti localmente difesa e rilanciata sino ad approdare all’ultima edizione – 2010 – dello Statuto del Collegio.
Chi poi chieda al suo attuale presidente – reduce, tra l’altro, da prestigiose e tutt’altro che brevi esperienze al vertice dell’Aniai – di riassumere in una battuta il senso di questa scelta, si sente rispondere che si è trattato di una scommessa. Seppur radicata, potremmo chiosar noi, nella stessa storia dell’associazione, pavese e più largamente lombarda.
Certo, la distinzione dei ruoli non può che giovare a chi voglia muoversi con la maggior possibile libertà a livello propositivo, beninteso scommettendo sulla propria capacità di interpretare istanze più o meno diffuse – direbbero i politici – alla base, e in tal modo raccogliendo quelle libere adesioni, che sole possono sostenere, anche materialmente, nel tempo, l’azione del sodalizio.
È comunque un campo difficile da arare, particolarmente per la presenza sul territorio di interessi diversi e spesso contrapposti. E a chi regge la barra si chiede coraggio ma insieme prudenza. Si danno però anche possibilità – un tempo assenti – di ripartizione dei compiti. Talune battaglie possono esser meglio condotte da associazioni che non abbiano come fine primario la promozione della cultura professionale dei propri iscritti e pure esistono e hanno alle spalle una storia di incontri e scontri taluni persi altri vinti, con gran vantaggio della collettività. Mi si consenta, al riguardo, di ricordare come proprio quel Convegno sul Centro storico, voluto e organizzato dal Collegio, segnò nel ’64 un punto alto di convergenza tra il Collegio stesso e una schiera di cattedratici dell’Ateneo, nella fattispecie della Facoltà di Lettere, che di quegli incontri e scontri furono tra i più impegnati protagonisti.
Avendo, trent’anni dopo, tentato di riprendere con alcuni colleghi ed amici le fila di quel discorso, anche a seguito delle cortesi sollecitazioni di chi – l’ing. Testa – del precedente convegno era stato, per volontà del Collegio, il coordinatore, sarei poi stato straordinariamente gratificato non solo dalle dichiarate simpatie, ma, e più, dall’impegnata partecipazione di tanti nostri colti professionisti. Che a quel nuovo incontro, battezzato “Spazio urbano ed extraurbano a Pavia dall’età classica alle soglie del Duemila”, avrebbero offerto preziosi contributi.
E come non ricordare l’altra importante iniziativa, cui il maggior esperto di storia del Collegio pavese ebbe pur a dare importanti contributi, e vide l’agguerrita partecipazione di illustri ingegneri, matematici, economisti, della nostra e di altre Università, ma altresì di storici della nostra Facoltà di Lettere, concretizzandosi nel ricchissimo volume celebrativo del quarantesimo di rifondazione della nostra Facoltà di Ingegneria? Virtuosi circuiti, come già fu per Milano all’indomani dell’unificazione nazionale, possono dunque tornare a prodursi anche in una realtà pavese segnata, ovviamente in positivo, da questa nuova, fondamentale, presenza.
Basteranno queste notazioni a confortare, almeno un poco, chi quotidianamente si trovi ad affrontare un mare in apparente calma, in realtà turbato nel profondo da procellose correnti?
Mi si potrebbe rispondere, dati e pubblicazioni alla mano, che il Collegio non ha mai cessato di far sentire la propria voce pur in tempi e occasioni particolari non facili ed è ben vivo e attivo. E – anche solo circoscrivendo le citazioni all’ultimo venticinquennio – ricordare l’elaborata ricerca, pubblicata a mezzo degli anni Ottanta, sulle “Prospettive per gli anni duemila” di Pavia e provincia, seguita a breve da quella sui “Problemi della viabilità e dei parcheggi nel centro storico di Voghera”, nonché, di poco successive, dalle “Ipotesi progettuali per la revisione del piano regolatore” di Vigevano e dalle “Proposte di riassetto della viabilità e di isola pedonale” per Mortara. E ancora citare gli articolati interventi del ’93, ’99 e 2000 inrelazione, il primo, alla variante al Piano regolatore generale di Pavia, il secondo e il terzo al nuovo Piano, senza dimenticare anche più pratici, preziosi interventi, come, per citar solo l’ultimo in ordine di tempo, quell’accordo per lo “Snellimento delle procedure di presentazione delle istanze edilizie ed urbanistiche” preso col Comune dal Comitato interprofessionale edile per la nostra provincia di cui il Collegio è attiva parte.
Soci giovani e anziani nutriti di buona cultura classica potrebbero però sensatamente obiettare che dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur, ossia, fuor di metafora, che mentre ci occupiamo di aspetti specifici della nostra come di altre città della provincia, la briantizzazione del territorio che da Milano fisicamente ci ha, nel tempo, separato minaccia la stessa sopravvivenza di Pavia come realtà urbana relativamente autonoma. Né si tratta di combattere ipotetici nemici milanesi, in un del tutto improbabile remake medievalizzante. Perché il nemico è ovunque, nell’autarchico proliferare di piani che sempre più guardano ad interessi e certo lecite aspirazioni locali, ma ahinoi gravide di catastrofici stravolgimenti a più ampia scala. Mentre l’organizzazione dei famosi parchi – progettati per fermare la cementificazione di un territorio dalla storica vocazione agricola – interpreti e protagonisti di quella storia essendone, tra l’altro, gli ingegneri di un nostro glorioso passato – segna il passo, quando non viene addirittura posta in dubbio da disastrose operazioni edificatorie.
Se fuori le mura questa è la minaccia, dentro le mura non mancano problemi sui quali non è qui il caso – enumerandoli partitamente – di immalinconirci, e del resto appaiono raggruppabili sotto il comune denominatore di una più o meno dichiarata e altrettanto autarchica libertà di iniziativa dei diversi portatori di idee e corrispondenti mezzi finanziari.
Cui si può, e a me pare si dovrebbe, rispondere, da parte delle associazioni culturali e degli organismi professionali, coordinandosi in una azione congiunta e determinata di tutela della città e del suo territorio da iniziative incompatibili con la salvaguardia dei suoi valori storici e ambientali, stimolando, nel contempo, scelte politico-amministrativi.
Tratto da: “150 ANNI, eventi tra cronaca e storia; dal 1399 al 1860 al 2010, eventi tra cronaca e storia e 150 anni di impegno del Collegio”, anno 2010. Il Collegio degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Pavia, stampa 2011, Industria Grafica Pavese.